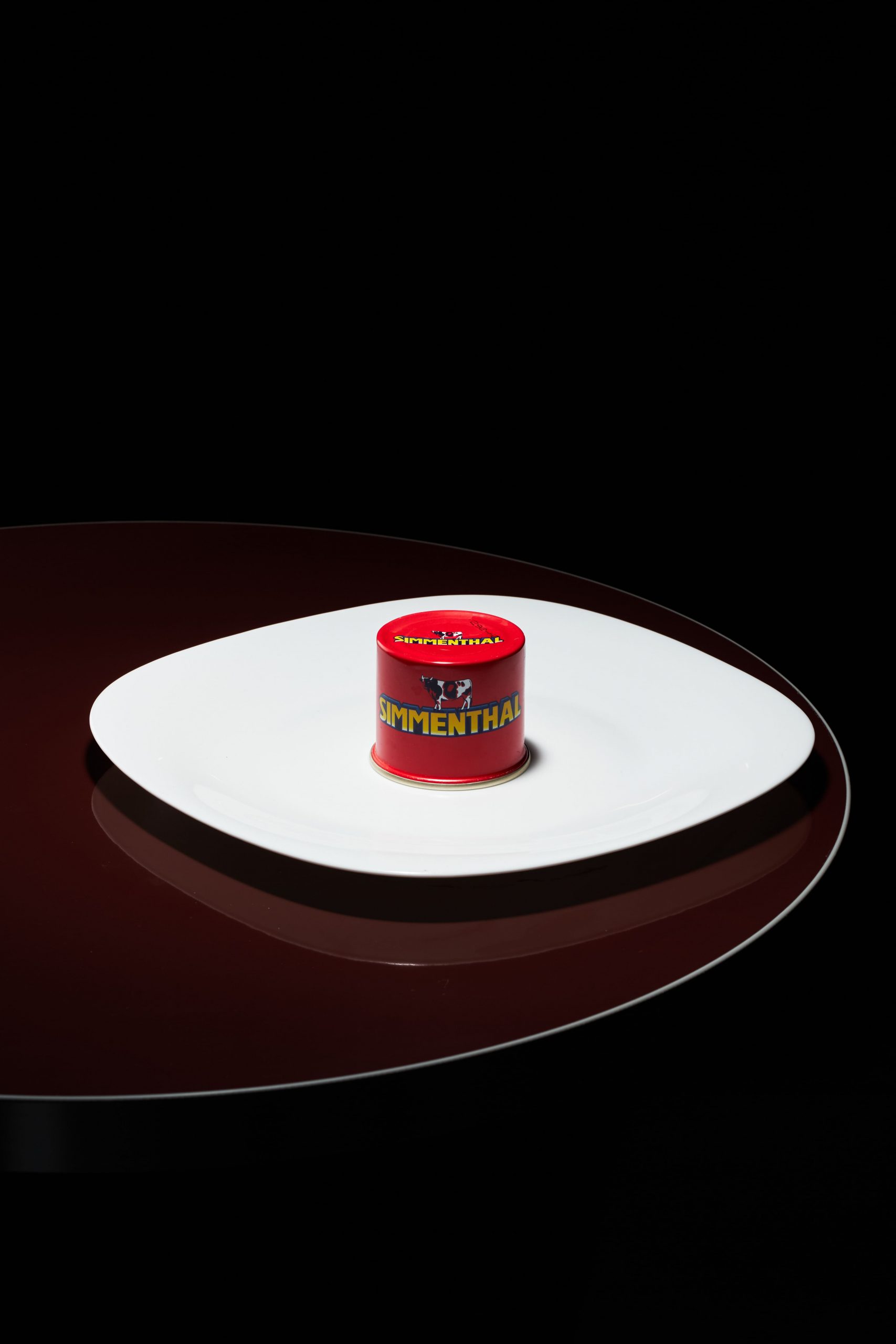Tornando ai pizzosi cinquantenni: il grosso problema del bar in questo momento non è certo un nuovo locale che fa un po’ di chiasso in più. È la comunicazione dell’intero settore a fare acqua. Le realtà e gli individui che si proclamano come esperti, non si fanno neanche lo scrupolo di andare a toccare con mano quello di cui parlano, ma si limitano a riferire un sentito dire. E quelli che invece provano e raccontano, vengono bombardati di epiteti se la pensano diversamente dalla massa. Il risultato è tutto nella risposta dell’utente medio: siamo uno dei pochissimi paesi europei in cui ancora l’idea del cocktail bar è legata all’ubriacatura senza mezzi termini, non c’è un briciolo di consapevolezza su cosa un locale incentrato sul bere possa effettivamente offrire (non deve piacere, ma si deve almeno conoscere). E alla fine si finisce per avere generazioni (non giovani, perlopiù), che danno per scontato di poter chiedere una pizza ovunque, e quando non la trovano non si spingono oltre per provare qualcosa di nuovo.
Se chi si suppone lavori nella comunicazione del bar, si impegnasse di più a divulgarlo come si deve, con opinione giustificata e competenza, invece di soli selfie, ne gioverebbe il sistema tutto, perché anche i bevitori non addetti ai lavori avrebbero qualcosa in più da imparare, sperimentare e apprezzare. E di conseguenza, i bartender che si fanno un sedere così, a prescindere dalla filosofia del loro locale, potrebbero godere ancora di più della loro passione. Infine, una buona idea sarebbe quella di dare a Carola, Mario e Gianluca, così come a chiunque decide di fare questo meraviglioso e maledetto lavoro, un po’ di tempo: mi sembra sempre più spesso si sia persa la visione della realtà, si commentino i risultati o il progresso di un’attività dopo poche settimane d’apertura. Servirebbero anni per poter davvero avere il polso di un’insegna, capire come ha incrociato i gusti di quel quartiere, di quel momento storico, della sua platea; invece si continua a raccontare di imprenditori con la bacchetta magica, bartender che da un giorno all’altro scoprono la pietra filosofale e pretendono di intascare quattro cifre a sera per delle guest nights che interessano solo a qualche collega (e dove nella grande maggioranza dei casi si beve malissimo).