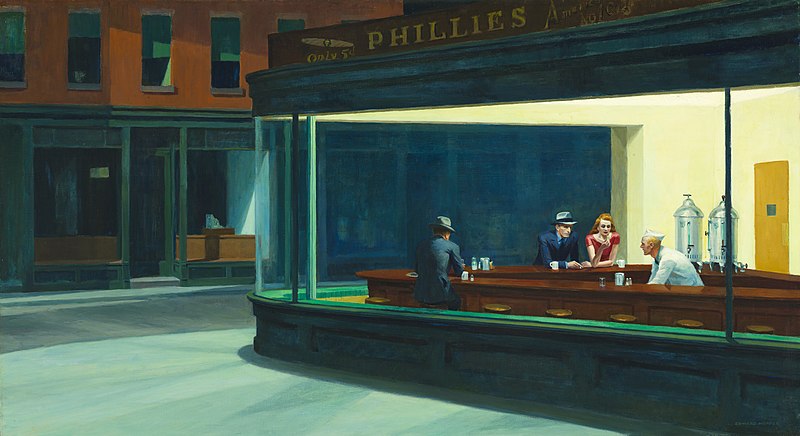Bartender che aprono locali per compiacere altri bartender, senza curarsi di avere una struttura solida, soddisfare gli avventori e soprattutto tenere i conti in ordine, eppure tronfi di aver ricevuto un re-post su Instagram dal collega che “è molto seguito”, ma alla fine fa video casalinghi, fa consulenze (altro mostro mitologico) e manco sarebbe capace di tenere i ritmi di un bar serio, in centro. Bar che, tutti, “mettono le persone al primo posto per vivere un’esperienza di convivialità”, che vogliono solo “far star bene, far staccare la spina”; e poi costringono gli ospiti a sorbirsi quante ridistillazioni ha fatto quella lacrima di unicorno, e come ha fermentato quello sciroppo di ostrica, nel massimo del controsenso (se vuoi far rilassare qualcuno, magari tediarlo non è il caso, per le spiegazioni torniamo all’università).
Quello che sembra (di nuovo, o ancora) mancare è l’essere votati a questo universo balordo. Essere osti è una scelta, prima di tutto: dedicarsi all’ospite per il suo benessere, e non per il proprio ego o la propria soddisfazione. Quando un bevitore apre la porta di un bar, dimostra di aver scelto quell’indirizzo tra mille. Magari piove ed è uscito comunque, per festeggiare con il partner, con gli amici, da solo. In una marea straripante di offerta, che si sta pericolosamente appiattendo verso una massa indistinguibile, tra Instagram tali e quali e vermouth homemade (fatto in casa vuol dire la stessa cosa), qualcuno ha scelto quella sera di venire a trovare proprio voi, nella speranza di trascorrere un paio d’ore senza dover pensare al cellulare, al lavoro, a qualsiasi ansia che la vita di oggi, di adesso anzi, è lì a consegnare. Un bartender dovrebbe tacere per la maggior parte, raccontare quando richiesto, sorridere spesso, accogliere sempre. E porca miseria, conoscere i classici come i nomi dei propri familiari; a nessuno, o quasi, interessa il numero di giri che avete fatto fare al vostro rotovapor, se poi non sapete fare un Martinez perfetto.